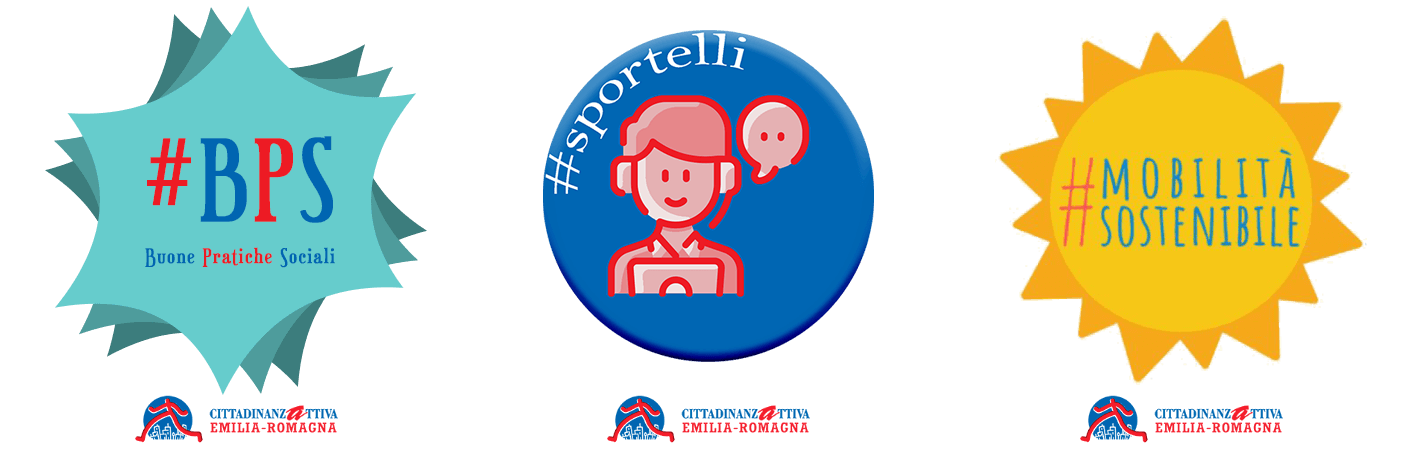Articolo scritto da: Avv. Elena Menetti*
Merita una breve riflessione il testo del Disegno di Legge cd. Gelli in materia di responsabilità professionale nel settore medico, approvato dalla Camera il 27 gennaio scorso ed ora al vaglio del Senato.
Al di là di altri pur rilevanti parti del testo del DDL, credo valga la pena soffermarsi su un punto in particolare, ovvero la previsione secondo cui l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.
L’inquadramento della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria nell’ambito della responsabilità da fatto illecito appare ictu oculi una forzatura.
Il paziente che si rivolge al medico conclude pacificamente un contratto; se questo appare evidente laddove sia il paziente a scegliere il medico ed il rapporto che si instauri sia un rapporto di tipo libero professionale, non diversa è la situazione laddove il paziente venga curato o sia affidato ad un medico convenzionato o semplicemente, e come più frequentemente accade, ad un sanitario che operi all’interno di una struttura ospedaliera come dipendente.
In questi ultimi casi, la giurisprudenza granitica, sia di merito che di legittimità, inaugurata nel lontano 1999 con la sentenza della Corte di Cassazione, III sezione del 22/01/1999, n. 589, ha consacrato il principio del cd. contatto sociale.
Il contatto sociale qualificato si pone nel nostro ordinamento come momento fattuale, prima ancora che giuridico, in grado di instaurare una relazione contrattuale fra soggetti, a prescindere dalla sussistenza di un contratto in senso stretto.
Con il termine “contatto sociale” ci si vuole riferire, più in generale, alle ipotesi di rapporto contrattuale di fatto, ossia a quelle ipotesi in cui un rapporto nasce sul piano sociale e nella sua fase fisiologica e funzionale rimane sul piano del fatto e in questo dovrebbe esaurirsi ma che, a fronte di una patologia nel rapporto, viene portato a conoscenza dell’interprete che, dovendolo tradurre sul piano del diritto, lo qualifica come rapporto di natura contrattuale.
Dal contatto sociale qualificato derivano quindi obblighi di tutela di determinati interessi, sorti in itinere o esposti a pericolo in ragione dello stesso contatto, tali da giustificare l’affidamento della controparte.
Ma vi è di più.
La professione medica, come noto, rientra le tre professioni c.d. protette, per l’esercizio delle quali è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato (art. 348 codice penale).
Si tratta inoltre di professione che ha ad oggetto un bene, la salute, costituzionalmente garantito.
Ne consegue che, ritenere, come vorrebbero i riformatori, che l’esercente la professione sanitaria sia tenuto nei confronti del paziente, a rispettare soltanto il precetto generale dell’art. 2043 c.c. (sintetizzabile nel comando di non nuocere al prossimo: alterum non laedere), valido per la totalità dei soggetti, anche non esercenti la professione sanitaria, e non debba invece rispettare l’obbligo di diligenza professionale posto dall’art. 1176 co. II c.c., appare riduttivo della funzione sociale dell’esercente la professione sanitaria, oltre che lesivo nei confronti degli utenti-pazienti.
Se questo è vero, al medico non ci si può limitare a chiedere un non facere, cioè un puro rispetto della sfera giuridica altrui, ma quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l’attività medica in ogni momento.
Ma come viene giustificato dagli autori e sostenitori della riforma l’inquadramento nella responsabilità da fatto illecito per le professioni sanitarie?
Da un lato, si adduce una garanzia di maggiore serenità al medico che opera, dall’altro si vorrebbe arginare il fenomeno della cd. medicina difensiva e quindi contenere la spesa pubblica.
Sull’ultimo punto, ci si permette di azzardare la seguente considerazione.
La riforma, così come approvata alla Camera, comporterebbe l’inapplicabilità al sanitario del limite alla responsabilità del prestatore d’opera posto dall’art. 2236 c.c. (in materia contrattuale), ciò rischia di dare nuova linfa proprio a quell’atteggiamento “difensivo” che in realtà si vorrebbe debellare.
Senza omettere di dire che la pretesa ‘serenità’ del medico andrebbe a scapito del paziente danneggiato, il quale si ritrova con un più oneroso onere della prova a proprio carico, oltre che un termine prescrizionale dimezzato per fare valere i propri diritti.
Vale la pena spendere due parole anche sul diverso onere della prova.
Anche su questo punto, la giurisprudenza ha elaborato il principio di cd. “vicinanza o prossimità della prova”, in forza del quale la prova deve essere data dalla parte che più facilmente può accedere alla fonte di prova, indipendentemente dal suo ruolo all’interno del processo (Cass. n.13533 del 2001).
Trattasi di principio di formazione giudiziale avente le sue radici nell’art. 24 della Costituzione che, nel garantire a tutti il diritto di difesa e di azione in giudizio, vieta contemporaneamente di interpretare la legge in modo da renderne impossibile, o eccessivamente difficile l’esercizio.
Tramite il principio di vicinanza della prova, lo schema tradizionale dell’art. 2697 codice civile viene rovesciato e la prova non incombe più ei qui dicit, cioè sull’attore, bensì sulla parte nella cui sfera d’azione si è svolto il comportamento che ha causato il fatto di danno, quindi su chi meglio può fornire le prove di come si sono svolti i fatti.
Chiaramente questo criterio ha una diffusa applicazione nei casi di rapporti professionali ed obbligazioni che comportano prestazioni con elevato tecnicismo, nelle quali una parte si affida all’altra senza possedere le conoscenze specifiche che gli permettano, in seguito ad una eventuale azione di responsabilità, di provare che è mancata la diligenza specifica richiesta al professionista.
Questo è quanto si verifica nell’obbligazione medica, ove il suddetto principio ha un particolare impatto.
E’ evidente che il criterio suddetto attiene alla condivisibile esigenza che l’ospedale ed i medici rendano intellegibile e trasparente il percorso alla base delle proprie scelte terapeutiche e siano in grado di dare ragione delle scelte terapeutiche e delle cure prestate.
Appare quindi chiaro l’intento del legislatore di scoraggiare il ricorso alla giustizia da parte del paziente o utente della Sanità che abbia subito una lesione del diritto alla salute ed alle cure, diritto peraltro costituzionalmente garantito.
Alla luce delle superiori considerazioni, credo sia legittimo avanzare dubbi di incostituzionalità del provvedimento in questione che, con un colpo di spugna, vorrebbe cancellare lustri di elaborazione giurisprudenziale.
*Elena Menetti è un avvocato che collabora con Cittadinanzattiva di Bologna