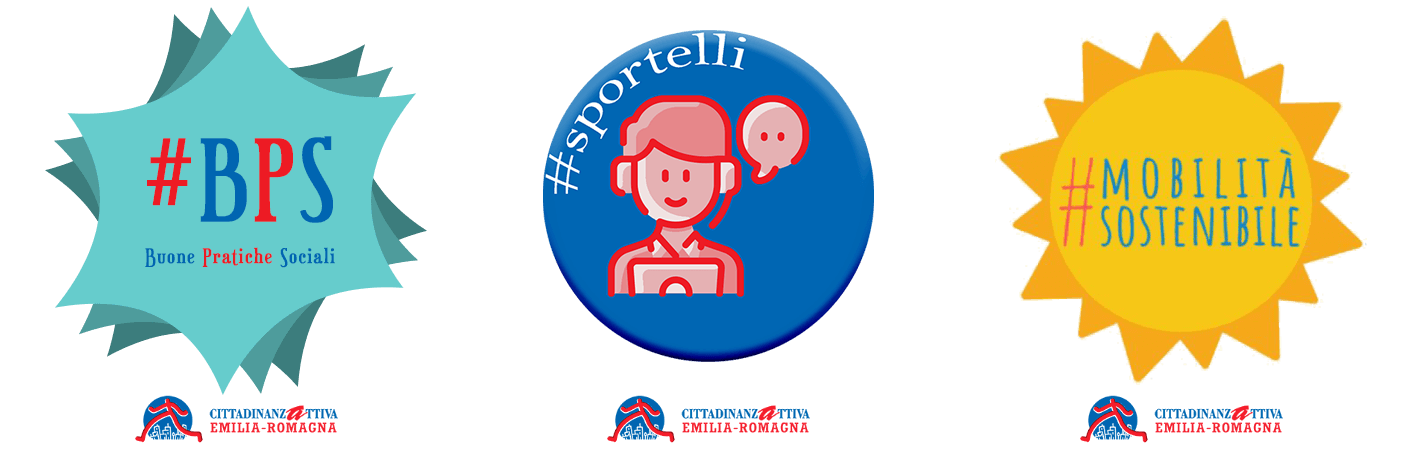di Walther Orsi
Questo tempo, caratterizzato dal contagio del ‘coronavirus’, ci ha fatto scoprire una situazione di emergenza completamente nuova rispetto al passato. Avevamo già sperimentato situazioni ed eventi molto gravi, causati da terremoti, frane, valanghe, trombe d’aria e uragani, che avevano provocato morti, feriti, gravi danni, disagi, traumi psicologici e condizioni di grande stress. Eppure l’esperienza che stiamo vivendo si caratterizza in modo completamente diverso ed è per questo che ci sentiamo tutti disorientati, impauriti, in difficoltà. Stiamo sperimentando una situazione di grande incertezza e fragilità che non appartiene alla nostra esperienza e che ci trova quindi completamente impreparati.
In questo periodo mi sono interrogato su quali sono gli elementi nuovi che caratterizzano questa emergenza. In fondo anche questo è un modo per esorcizzare la paura, ma forse anche un tentativo di guardare avanti per ipotizzare un futuro migliore. Provo a elencare qui di seguito ed in modo sintetico tali elementi:
• le cause di questo virus sono ancora abbastanza sconosciute;
• non sono ancora pienamente definite le modalità di diffusione del virus;
• non sono ancora validati dei sistemi di prevenzione e di terapia per combattere questa patologia;
• siamo di fronte a una vera pandemia perché la diffusione non è più solo locale, ma interessa tutto il pianeta;
• questo virus colpisce prevalentemente le persone anziane e con precedenti patologie, ma tutte le persone sono potenzialmente a rischio;
• non sono ancora chiare le motivazioni per cui la diffusione del virus è disomogenea a livello territoriale;
• l’evoluzione dell’emergenza non era prevedibile e quindi anche gli interventi sanitari e di protezione civile hanno dovuto tenere conto, giorno per giorno, dei dati relativi ai contagiati, ai morti, ai guariti;
• la programmazione degli interventi sanitari e di protezione civile ha dovuto tenere conto dell’evoluzione della capacità dei cittadini di comprendere i rischi relativi ai propri comportamenti, ma anche di maturare un cambiamento degli stili di vita;
• le risposte all’emergenza del ‘coronavirus’ hanno richiesto alleanze, non sempre realizzate, fra molteplici attori sociali: scienziati, esperti, politici, operatori sanitari e della protezione civile, giornalisti, attori, cantanti, opinion leader. Ma tali risposte hanno promosso soprattutto una responsabilizzazione di tutti i cittadini;
• in questa emergenza è stato fondamentale il ruolo degli interventi informativi, promozionali, educativi;
• questa emergenza ci ha fatto scoprire il valore, la capacità e la grande motivazione degli operatori sanitari e della protezione civile. Ci ha fatto anche scoprire i limiti di tali servizi. Non a caso si è provveduto a coinvolgere nuovi operatori sanitari che avevano appena completato il percorso formativo, medici neo pensionati, associazioni di volontariato, cittadini volontari e donatori di sangue.
Per ora, essendo ancora immersi nell’emergenza, penso non sia possibile andare oltre queste prime valutazioni. Mi limito a sottolineare ancora una volta il ruolo centrale del servizio sanitario nazionale e della protezione civile che hanno cercato sempre, con grande impegno e motivazione, di rispondere in modo adeguato ai bisogni della popolazione, mettendo a rischio la propria vita. Ad essi va il mio più sincero ringraziamento.
Credo anche che il coordinamento a livello nazionale, regionale e locale, svolto dai politici, dagli amministratori, dagli esperti e tecnici, abbia fatto tutto il possibile di fronte a questa grave emergenza. Le risposte fornite sono state orientate dalla necessità di individuare una mediazione fra chiusura totale di tutte le attività a livello nazionale e provvedimenti articolati per ambito operativo e per area territoriale. L’Italia ha dimostrato, ancora una volta, di saper affrontare questa difficile situazione. Non a caso si è iniziato a parlare di ‘Modello Italia‘ che è stato imitato da altre nazioni. Di questo dovremmo essere tutti orgogliosi.
In questa fase, in cui non abbiamo ancora chiaro l’evoluzione e le conseguenze del fenomeno ‘coronavirus’, credo sia importante non dimenticare ciò che stiamo vivendo, ma soprattutto cogliere gli insegnamenti che ne possiamo trarre.
Occorre ricordare che le grandi innovazioni socio-culturali dell’umanità sono sempre state conseguenti a gravi eventi della storia, o a profondi cambiamenti a livello socio-economico. Ne faccio solo alcuni brevi accenni.
La diffusione, nel diciassettesimo secolo, di nuove modalità di produzione, legate all’introduzione della macchina a vapore nelle manifatture, provocò grandi processi di urbanizzazione della popolazione, che originarono anche gravi situazioni di povertà. Per rispondere a tali fenomeni, che non erano più gestibili solo attraverso forme di carità privata, diversi stati iniziarono a sviluppare interventi di beneficenza pubblica.
La rivoluzione industriale che si è affermata, con tempi diversi, nei vari contesti territoriali, ha prodotto un enorme sviluppo economico, ma anche notevoli problemi subiti dai lavoratori che inizialmente furono gestiti attraverso lotte operaie, forme di mutuo soccorso e di solidarietà, ma poi richiesero politiche ed azioni pubbliche a carico dello stato e delle amministrazioni locali, attraverso interventi di tutela della maternità, sistemi pensionistici, forme di assistenza in caso di invalidità e povertà, mutue sanitarie, ecc…
La grande depressione economica, a partire dal 1929, e le gravi conseguenze provocate dalla seconda guerra mondiale, generarono situazioni molto diffuse di disoccupazione, povertà e di bisogno che spinsero molti stati dell’occidente ad avviare sistemi di welfare, orientati dal principio dell’universalismo e quindi tesi ad assistere tutti i cittadini indipendentemente dalla loro situazione lavorativa, sociale, culturale.
L’insegnamento che possiamo trarre da questa pandemia è che oggi siamo chiamati a inventare e a progettare un ‘Sistema di prevenzione e protezione‘ profondamente innovativo, fondato su un ‘Nuovo patto fra Amministrazione pubblica e Cittadini‘ che sia in grado di prevenire e affrontare nel futuro, a livello globale e non solo locale, eventuali altre emergenze come quella del ‘coronavirus’.
Non è facile prevedere le caratteristiche specifiche di queste future emergenze, anche perché nessuno avrebbe immaginato quella che stiamo vivendo. Senza voler essere catastrofisti o pessimisti, credo però che esistano tanti segnali oggi nel mondo che ci fanno intravvedere alcuni scenari di eventuali future emergenze. È sufficiente immaginare le possibili conseguenze legate al riscaldamento globale, alla fame nel mondo, alle guerre, alle crescenti migrazioni, alle violazioni dei diritti umani in tanti contesti territoriali, alle sempre maggiori disparità economiche in cui vivono le popolazioni non solo a livello mondiale, ma anche a livello locale, quindi anche qui in Italia.
A questo proposito sarà giusto ricordare, anche quando avremo superato questa emergenza, quello che tanti di noi hanno detto in questo periodo, ben sintetizzate da Federico, un volontario di Cittadinanzattiva: “molte cose dovranno cambiare perché il virus ci sta mostrando le vere priorità e i falsi miti che ci hanno fatto in parte smarrire il senno”.
Che cosa dovremo cambiare allora? Provo a dare alcune possibili risposte, nella consapevolezza che, come dice Papa Francesco, “non possiamo pensare di rimanere sani in un mondo malato”.
Ogni persona sarà invitata a interrogarsi periodicamente sull’impatto dei propri comportamenti a livello sociale, culturale, ambientale ed economico. Non sarà facile disabituarsi ad atteggiamenti e comportamenti che abbiamo sempre creduto fossero normali, come ad esempio: avere rapporti solo formali con i nostri vicini di casa, vivere con preoccupazione e pregiudizio i fenomeni migratori, ritenere che le attività turistiche possano essere valutate solo per il loro contributo positivo all’economia, senza cogliere anche le conseguenze negative a livello ambientale, sottovalutare e tollerare i gravi effetti dell’evasione fiscale, anche in termini di tagli alla spesa pubblica, promuovere in modo esasperato i consumi senza cogliere anche gli effetti perversi di questi comportamenti a livello sociale, culturale ed ambientale.
Tutti i cittadini saranno chiamati a superare un approccio prevalentemente individualista, che abbiamo maturato in questi ultimi decenni, per assumere atteggiamenti e comportamenti orientati dai valori civici e dalla volontà di partecipare alla costruzione di una comunità educante e solidale.
Gran parte delle emergenze che abbiamo vissuto ci hanno dimostrato che non possiamo fare affidamento solo agli addetti ai lavori (politici, amministratori, servizi, esperti, professionisti, associazioni), ma anche a una responsabilizzazione diffusa di tutte le persone di buona volontà e quindi a una cittadinanza attiva.
Negli ultimi anni abbiamo scoperto che molte emergenze potevano essere evitate attraverso interventi preventivi. Credo sia venuto il tempo di investire risorse pubbliche e private, azioni professionali e di volontariato per sviluppare un sistema esperto non solo di pronto intervento, ma anche di prevenzione di molte emergenze. Sarà necessario non solo fare una mappa dei rischi relativi ai singoli territori e alle loro comunità, ma anche individuare e dare rapida attuazione a specifici piani di rimozione degli stessi. In tale prospettiva anche la protezione civile e il pronto intervento socio-sanitario non potranno più essere considerati solo servizi specializzati nella gestione delle emergenze, ma componenti fondamentali di un ‘sistema esperto’ nella diffusione di culture, conoscenze e interventi per la prevenzione dei rischi e per la promozione della qualità della vita.
Questo sistema non può essere catalogato solo come un ambito del welfare, che evidentemente rischia di pesare ulteriormente sulla spesa pubblica, ma come un nuovo settore imprenditoriale, produttivo e di lavoro in grado di ridefinire gli obiettivi, le strategie, le opportunità di un altro sviluppo socio-economico e culturale (più equo, solidale e sostenibile) che possa fare riferimento a forme innovative di investimenti pubblici, privati e di cittadinanza attiva e che sia misurabile non solo con il PIL, ma con indicatori di benessere e di qualità della vita.
Questo sistema non può caratterizzarsi solo in un ambito nazionale o locale perché i rischi delle nuove emergenze avranno sempre più una rilevanza globale. Saranno necessarie quindi forme di prevenzione e protezione concordate a livello europeo e mondiale, attraverso interventi di solidarietà e di mutuo soccorso internazionale che impegnino la Comunità europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In questa prospettiva, per cercare di superare la situazione di emergenza in cui siamo ancora immersi, cosa possiamo fare fin da subito? Secondo il sociologo Stefano Allievi è necessario promuovere una gigantesca operazione di ridistribuzione per contrastare i sintomi di una “doppia polarizzazione sociale” che presto si abbatterà sulle nostre comunità. La prima polarizzazione separa quella parte di popolazione che dispone di riserve (materiali, finanziarie, cognitive, relazionali) e l’altra parte che invece non le ha. Secondo Paolo Gubitta (Corriere di Bologna del 18/3/2020): “vanno promossi e sostenuti comportamenti di ‘cittadinanza attiva’, basati sulla capacità della popolazione di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse di qualsiasi tipo, e di agire con logiche specifiche e responsabili per tutelare e prendersi cura dei beni comuni. Ci servono solidarietà e generosità di vicinato”. Ad esempio: “telefoniamo alle persone che sappiamo essere sole”; “rendiamoci disponibili per supportare chi ha bisogno (adesso) di una mano; prestiamo denaro a conoscenti che ne hanno letteralmente bisogno per arrivare a domani o dopodomani; condividiamo le risorse (anche aziendali) con chi ne ha necessità (adesso)”. La seconda polarizzazione è quella che separa chi “ha un posto di lavoro e lo stipendio che non dipendono in modo diretto e immediato dalle dinamiche di mercato, perché garantiti dalla mano pubblica e chi invece sa fin d’ora che posto di lavoro e stipendio sono messi a rischio dall’inevitabile contraccolpo economico con cui faremo i conti appena usciremo dal tunnel dell’emergenza”. Sempre secondo Paolo Gubitta è necessario lanciare un segnale forte. “Come farlo? Chi ha uno stipendio pubblico più che adeguato rispetto alle proprie esigenze si renda disponibile per un ‘prelievo volontario e temporaneo dallo stipendio’, mettendolo a disposizione di chi, senza colpa, rischia il collasso personale, famigliare o aziendale. Se a questa azione di ‘cittadinanza attiva’ si aggiungessero anche tutte le persone benestanti a prescindere dalla natura del datore di lavoro, avremmo fatto una cosa buona e giusta”. In questa prospettiva stanno nascendo iniziative pubbliche e private che si caratterizzano come ‘Fondi di mutuo soccorso’, o ‘Fondi anticrisi’, ‘Aiuti internazionali’ e tendono ad assumere crescente importanza le buone pratiche sociali dei cittadini e degli imprenditori.
Credo che i vari interventi avviati possano costituire i primi fondamenti di quel Sistema di prevenzione e protezione, centrato su un nuovo patto fra amministrazione pubblica e cittadini a cui ho fatto riferimento in precedenza. Anche in questo caso, come in passato in occasione delle grandi innovazioni socio-culturali dell’umanità, è prioritario il ruolo dell’amministrazione pubblica e dei relativi investimenti e interventi economici. Non si può fare riferimento solo alle organizzazioni che operano a livello locale, o nazionale, ma è necessario coinvolgere tutti gli organismi pubblici in ambito europeo e mondiale. In questa specifica occasione la Comunità europea è chiamata ad attivare e a coordinare un piano solidale di aiuti internazionali teso anche a sconfiggere le logiche nazionali e autoreferenziali spesso dominanti. In tale prospettiva l’amministrazione pubblica dovrà essere attenta ai bisogni, alle risorse, ai progetti, alle buone pratiche sociali dei cittadini, alle iniziative e alle sperimentazioni degli imprenditori, per incentivare, supportare, regolare e coordinare questo grande processo innovativo. Non possiamo solo invocare nuovi Piani Marshall, ma fare riferimento a tutte le iniziative di aiuto all’Italia, già attivate, che vanno ben oltre l’esperienza passata del secondo dopoguerra, perché coinvolgono nuovi paesi come Cina, Cuba, Russia, e a quelle che potranno essere incentivate attraverso nuove alleanze internazionali.