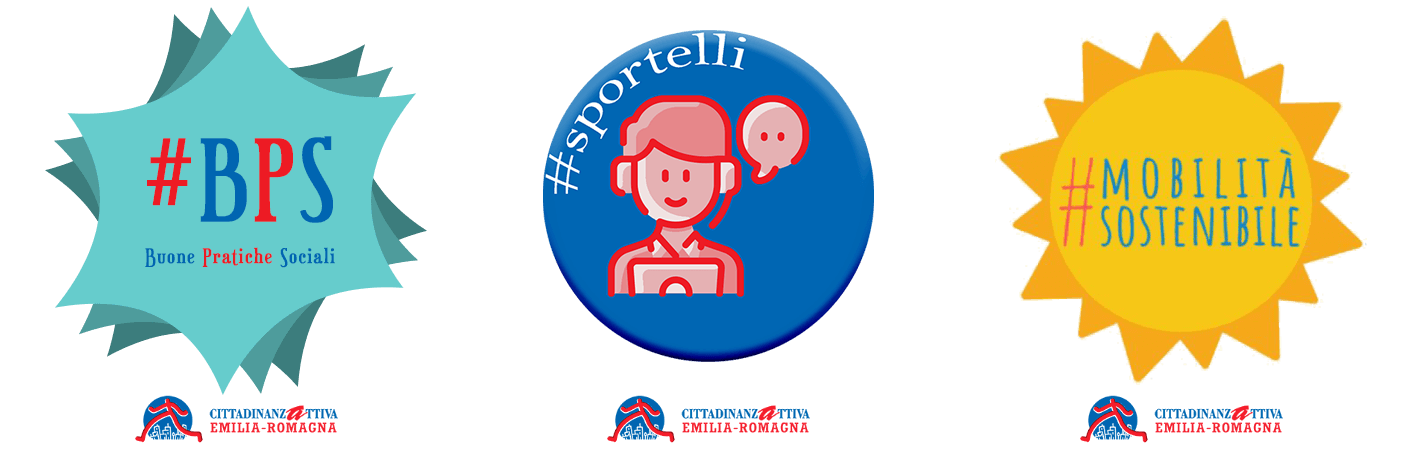a cura di Pasquale Falasca, Epidemiologo e Consulente Ministero della Salute
Dalla teoria sociale dell’apprendimento all’Intelligenza Artificiale
Le nostre istituzioni, nella misura in cui affrontano esplicitamente i problemi dell’apprendimento, si basano prevalentemente sull’assunto che esso sia un processo individuale, separato dal resto delle nostre attività, prodotto dall’insegnamento.
Di conseguenza, predisponiamo delle aule dove gli studenti possono seguire un insegnante o concentrarsi sullo svolgimento di un esercizio.
Progettiamo programmi di formazione al computer che offrono agli studenti sessioni individualizzate in cui ricevono enormi quantità di informazioni e possono sperimentare le nozioni apprese.
Per valutare l’apprendimento usiamo dei test in cui gli studenti si affrontano in una sorta di competizione, dove le conoscenze apprese vanno dimostrate fuori dal contesto pratico e la collaborazione viene considerata una forma di inganno.
Di conseguenza, molto della nostra formazione istituzionalizzata viene percepita in gran parte come irrilevante e che l’apprendimento sia un processo noioso.
La Comunità di Pratica adotta una prospettiva diversa, che inserisca l’apprendimento nel contesto della nostra esperienza concreta di partecipazione alla vita reale. Imparare fa parte della natura umana tanto quanto mangiare o dormire, che è vitale, che l’apprendimento è un fenomeno fondamentalmente sociale che riflette la nostra natura profondamente sociale di esseri umani in grado di conoscere.[1]
Sappiamo tutti che la scienza e la tecnologia svolgono un ruolo di primo piano nelle profonde trasformazioni che il mondo sta attraversando, in particolare in vista della loro stretta connessione con i domini dell’economia e della finanza.
Sappiamo anche che sta influenzando e modificando ogni dimensione dell’esistenza umana, comprese le relazioni sociali e la salute.
Negli ultimi anni la tecnologia ha attraversato cicli di sviluppo sempre più rapidi, producendo sempre più innovazioni.
Abbiamo assistito alla trasformazione digitale della tecnologia; l’emergere dei “big data” e un aumento esponenziale della potenza di calcolo.
L’Intelligenza Artificiale (IA) si rivela sempre più utile nella gestione della complessità a vantaggio di tutti; aiuta a ottimizzare la gestione delle risorse e offre preziosi benefici nel campo della medicina e della sanità.
Però, ogni giorno ci vengono proposti esempi di sfide all’etica dall’IA[2]; dal riconoscimento facciale alla profilazione degli elettori, dalle interfacce cervello-macchina ai droni armati e al dibattito in corso su come l’IA avrà un impatto sull’occupazione su scala globale.
L’IA ci pone di fronte ad interrogativi radicali: come l’umanità sarà in grado di mantenere il controllo in un’epoca in cui la macchina diventa capace di sostituire le decisioni umane?. Cosa può fare la macchina senza il controllo umano? Quali decisioni può prendere? Come gestire i possibili esiti nefasti di questa delega? Soprattutto, come fare in modo che la persona rimanga sempre al centro dei processi vitali per la sopravvivenza e la salute della nostra specie?
Con l’adozione dell’approccio della Comunità di Pratica è possibile perseguire un obiettivo comune, partecipare a riflessioni condivise e identificare soluzioni che sfruttino la nostra intelligenza collettiva, al fine di modellare lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale in modo da avvantaggiare il nostro pianeta.
Se siamo convinti che i collaboratori, nella nostra organizzazione, contribuiscano al perseguimento dei nostri stessi obiettivi, partecipando in modo creativo alle pratiche, che non potranno mai essere pienamente incorporate nei processi digitali dell’IA, allora cercheremo di minimizzare le prescrizioni, sapendo che un eccesso di prescrittività scoraggia quella stessa ideazione creativa che rende efficaci le pratiche operative.
Dovremo fare in modo, invece, che la tecnologia digitale e l’IA siano dei contesti entro i quali le comunità che sviluppano queste pratiche possano prosperare.
Dovremmo apprezzare il lavoro di costruzione delle Comunità e adoperarci perché i partecipanti possano accedere alle risorse necessarie (in particolare quelle messe a disposizione dall’IA) per imparare ciò che devono imparare per adottare la pratica.
[1] Questi pensieri sono tratti da. Etienne Wenger. Comunità di pratica – Apprendimento, significato e identità Raffaello Cortina Editore 2006
[2] Il maggior studioso italiano di etica delle tecnologie: internet e impatto del Digital Age, biotecnologie e biosicurezza, neuroscienze e neurotecnologie, è il prof. Paolo Benanti della Pontificia Università Gregoriana. Nel 2018 è stato selezionato dal Ministero dello sviluppo economico come membro del gruppo di trenta esperti che a livello nazionale hanno il compito di elaborare la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale.
Per approfondire:
Loretta Fabbri. Comunità di pratiche e apprendimento. 2007 Carocci Editore
Progetto PonGov Cronicità: promuovere le buone pratiche con strumenti ICT
il 1° luglio 2020 la Commissione Europea ha adottato la “European Skills Agenda“, in cui la formazione continua degli adulti svolge un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi fissati.
Partecipazione Emilia Romagna: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/communities-1/cos2019e-una-comunita-di-pratica
italia@montessori-for-life.org; www.montessori-for.life.org
Foto di Engin Akyurt da Pixabay