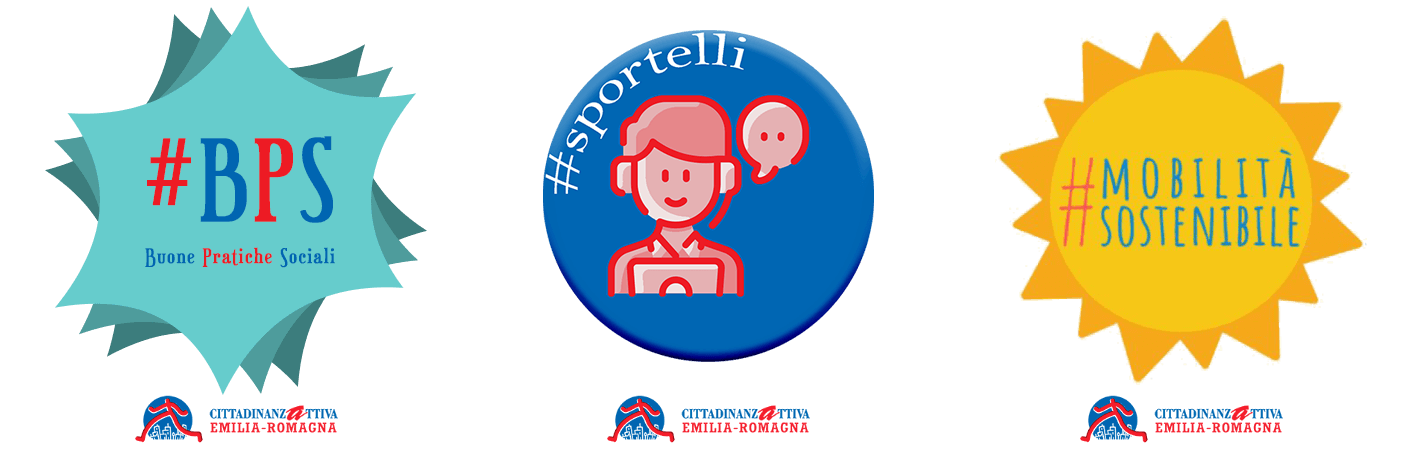A cura di Lidia Marsili, è stata dirigente nell’ambito della gestione delle risorse umane, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi. Scrittrice.
Ogni giorno la sua bellezza mi si rivela tramite la riscoperta di molte parole
Non ho mai amato i neologismi, soprattutto i forestierismi, che derivano da altre lingue.
Non sono portata per le lingue. Amo la mia.
Ogni giorno la sua bellezza mi si rivela tramite la riscoperta di molte parole, gettate nel dimenticatoio da una società distratta e noncurante, che ha fatto della riduzione della complessità e dell’omologazione la propria bandiera.
La violenza più subdola, che non si gioca su campi di battaglia ma su un’informazione che diventa sempre più estraniante e divisiva, cancella le differenze spegnendo la vita reale e donando l’illusione dell’eterno benessere e dell’eterna giovinezza.
Il “diverso”, che introduce elementi di disordine, viene isolato e accantonato.
Sono consapevole dell’impoverimento che rischio non assimilando altre lingue.
All’orizzontalità ho sempre preferito la verticalità. Amo andare in fondo non a zig zag.
Il parkinson divora e trasforma
Soffro della malattia di Parkinson da ormai undici anni. Ogni giorno perdo un pezzettino di me: della mia autonomia faticosamente raggiunta, della mia capacità cognitiva, della mia grazia. Non è solo questione di vecchiaia. Il Parkinson divora e trasforma.
Ricevere una diagnosi di Parkinson, come per tutte le malattie degenerative, è un’esperienza traumatica per il soggetto e per i suoi familiari ed è accompagnata da sentimenti personali di devastazione e perdita che convivono accanto a quelli di incertezza e sensazione di irrealtà.
I primi tempi ci si convive abbastanza bene. I farmaci riescono efficacemente a controllare la sintomatologia. Ma, con l’andare del tempo, le limitazioni, sia per l’avanzare della malattia stessa sia per la perdita di efficacia dei farmaci, diventano sempre più onerose e devastanti. Si diventa dipendenti da altri. Ed è una condizione difficilissima da accettare, soprattutto per chi è sempre stato fiero della propria autonomia e indipendenza.
Davide, compagno e caregiver
Guardo Davide, mio marito, di sottecchi, mentre, in cucina si dà da fare con il suo nuovo giocattolo, il bimby, per preparare il pranzo. Ho sempre gestito io la casa e la famiglia, pur lavorando. Ora non riesco più nemmeno a scolare la pasta. Le discinesie di cui soffro, oltre ai blocchi motori, non mi consentono di farlo. Correrei il rischio di rovesciarmi addosso l’acqua bollente e non solo.
Con enorme tenerezza lo osservo. Fino a poco tempo fa non sapeva neppure come si cuocesse una frittata. Ora sta diventando proprio bravo, soprattutto a cucinare le “verdurine”, come le chiama lui.
Davide, secondo la terminologia corrente, è il mio Caregiver.
Anche i nostri figli, in caso di estrema necessità, potrebbero diventarlo. In parte già lo sono. Mai lo avrei voluto. Ma la vita è imprevedibile.
Cosa significa questa parola che, al mio orecchio, suona malissimo?
Caregiver, formale e sostanziale
Caregiver è un termine di derivazione inglese il cui significato tecnico è: “colui che presta gratuitamente assistenza ad un familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non essendo più autosufficiente, è riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata.”
Nonostante l’abbia utilizzato per tanti anni nell’esercizio della mia professione, ora, rifuggo dall’asettico e impersonale linguaggio giuridico. Lascio ad altri, ai cosiddetti “tecnici”, l’analisi di questa figura. Io preferisco utilizzare il linguaggio del cuore.
Il caregiver è la persona che si fa carico, con amorevolezza, della gestione del proprio caro, malato, aiutandolo nelle incombenze quotidiane.
Essere un caregiver richiede un impegno e una dedizione costanti. Un atteggiamento di devozione totale che i latini erano soliti chiamare pietas. Un sentimento di amore, nel quale non rientra un semplice moto del cuore, ma anche una forte connotazione etica e morale.
Nell’antica Roma la Pietas era una divinità astratta, che rappresentava i doveri che l’uomo aveva verso i propri simili, in genere, e verso i genitori in particolare.
Una delle immagini più belle della letteratura, perfetto esempio del concetto di “Pietas”, è quella di Enea che, fuggendo da Troia in fiamme, trasporta sulle sue spalle suo padre Anchise, paralizzato agli arti inferiori.
Non c’è nulla che ritragga meglio il lavoro svolto giorno dopo giorno dal caregiver. Una presenza spesso silenziosa sulle cui spalle ricade un peso importante, spesso molto oneroso che, lentamente ma progressivamente, porta all’isolamento sia del malato sia di chi lo assiste.
L’accresciuta dipendenza del paziente da una figura che gli offra cure primarie costanti, comporta un notevole aumento del carico di assistenza da parte del caregiver, la cui qualità di vita finisce con l’essere fortemente compromessa.
Per me, Davide, è mio marito. È la persona con cui, in occasione del matrimonio, ho scambiato una promessa importante, quella di vivere insieme nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Amare quando tutto ti arride è facile; lo è molto meno quando la fatica e il dolore prendono il sopravvento.
Molti fuggono di fronte alle difficoltà. Il nostro sistema non educa alla responsabilità.
Davide non è fuggito. È rimasto con me.
Il senso della vita
In un mio libro, di prossima pubblicazione, intitolato “L’Alba dentro l’imbrunire”, d’impostazione autobiografica, ho trattato molti aspetti della malattia, non da un punto di vista clinico, ma da quello emozionale e relazionale.
La vita richiede sempre un continuo adattamento così come le relazioni umane che ne costituiscono una parte rilevante. La malattia introduce una vera e propria rivoluzione che comporta l’affinamento dell’empatia, della capacità di mettersi “nei panni dell’altro”, che funziona nella misura in cui c’è reciprocità. In mancanza di quest’ultima, le relazioni sono destinate al fallimento.
L’inizio è sempre difficilissimo. Per chi è malato è problematico comprendere la linea di demarcazione tra la propria volontà e il cambiamento indotto dall’assunzione di farmaci che la condizionano. Per chi assiste lo è maggiormente.
Conoscersi e conoscere è già difficoltoso di per sé in circostanze normali, soprattutto in un sistema improntato non sulla solidarietà ma sulla competizione. Accettare il cambiamento introdotto dalla malattia è un’impresa titanica, ma non impossibile.
Davide è la mia alba dentro l’imbrunire.
L’ accettazione della fragilità
In un bellissimo libro “L’arte di essere fragili”, ove tratta dell’importanza che Giacomo Leopardi ha avuto sulla sua formazione culturale ed emotiva, Alessandro D’Avenia scrive:
“Viviamo in un’epoca in cui si è titolati a vivere solo se perfetti. Ogni insufficienza, ogni debolezza, ogni fragilità sembra bandita. Ma c’è un altro modo per mettersi in salvo, ed è costruire, come te, Giacomo, un’altra terra, fecondissima, la terra di coloro che SANNO essere fragili”.
Perché l’amore è un’aggiunta di senso, un dono.
Perché l’indifferenza è soltanto sottrazione.
Perché è dall’esistenza dei limiti che s’impara a superarli.
La risposta vera ai problemi che la vita pone non è quasi mai la soluzione ad essi, ma l’apertura alla vita stessa di cui il domandare è il segno.
La soluzione è dentro la vita stessa e non fuori di essa. Aprirsi al dolore e abitarlo come una delle stanze del nostro cuore.
Toccando con mano le incomprensioni e gli equivoci che possono ingenerarsi quando la malattia irrompe nel nostro orizzonte quotidiano, rimanendo ferita da comportamenti dei miei familiari a cui la donna che ero per loro stava diventando estranea, ho provato, scrivendo, ad agevolare in loro una maggiore apertura verso di me per un verso e ad attivare in me, attraverso l’introspezione, una maggiore comprensione dei loro stati d’animo.
Avevo intuito che chiudersi in sè stessi, sentirsi vittime della vita, pretendere aprioristicamente un’attenzione non porta a nulla se non a viversi e a farsi vivere come un fardello e non come una risorsa. Ho compreso il valore ed il senso vero della parola “RECIPROCITÀ”.
Credo di essere riuscita nell’intento che mi ero prefissa.
Da quando ciascuno di loro, soprattutto mio marito, che vive con me tutti i giorni, ha letto ciò che ho scritto, è cambiato profondamente, così come credo di essere a mia volta cambiata.
Lui si fa carico di incombenze che prima evitava; io cerco di agevolarlo nei suoi interessi e assecondare la sua passione per il trekking, finché mi sarà possibile.
Capisco perfettamente il suo bisogno di evasione da una situazione sempre più limitante, per me e per lui e lui ha fatto propria la mia fragilità attuale, riconoscendo anche la sua.
Sostenersi insieme
Sostenendoci insieme, almeno per il momento, la fatica del vivere diventa più sopportabile. Anche se questo sforzo non è sufficiente a dare una riposta concreta ai problemi, concreti e materiali, che si presentano di giorno in giorno.
Una volta, nell’ambito della famiglia patriarcale, al di là dei limiti che la stessa aveva, le gioie ed i dolori venivano condivisi all’interno della stessa.
Il carico dell’assistenza era meno oneroso perché ciascuno forniva un proprio contributo.
Ora, l’isolamento a cui ci costringe il sistema cui viviamo, fa in modo che il peso dell’assistenza, sulla base della progressione della malattia, diventi intollerabile, rischiando di compromettere la salute stessa di chi assiste.
Non vorrei mai che mio marito si ammalasse a sua volta né che si arrivasse a situazioni limite di non ritorno.
L’isolamento può condurre a situazioni aberranti. La disperazione può condurre a gesti estremi, sempre più frequenti, come l’omicidio/suicidio, che la cronaca registra.
Io credo che, al di là dello sforzo di comprensione reciproca, sia necessario operare cambiamenti, sia a livello di organizzazione generale sia a livello relazionale esterno.
Riconoscere il Caregiver affinché il legame non si trasformi da dono d’amore ad obbligo giuridico
Un riconoscimento formale della figura del Caregiver, non accompagnato da misure ed azioni utili ad allievare il suo carico di lavoro, non è in alcun modo sufficiente, anzi corre il rischio di ritorcersi come un boomerang all’interno della famiglia.
È come se l’assistenza al proprio caro si trasformi da dono d’amore ad obbligo giuridico.
Per quanto riguarda il primo aspetto, avendo sperimentato direttamente, almeno a Bologna, le lacune del Servizio Sanitario Nazionale, bisognerebbe agire per un sistema di assistenza integrato, sin dalla diagnosi, che coinvolga più figure professionali, compresa la figura dello psicologo, di fondamentale importanza per un supporto adeguato a gestire le dinamiche relazionali familiari, soprattutto quando i soggetti coinvolti non hanno la sensibilità o le capacità per affrontarle da soli.
Sicuramente, il subdolo processo di privatizzazione della sanità, che passa anche attraverso una costante sottrazione di risorse del Servizio Sanitario Nazionale con conseguente tagli di servizi considerati non essenziali e di prima necessità, ed una carenza di programmazione di formazione delle figure professionali ritenute necessarie per garantire la prevenzione e l’assistenza in funzione dell’evolversi delle patologie, non favorisce lo sviluppo di questo processo di integrazione.
Sempre da un punto di vista organizzativo, sarebbe altresì necessario stimolare e favorire, anche con compagne promozionali, la formazione di associazioni a cui fornire un aiuto dall’esterno, sia in termini di finanziamenti sia in termini di supporti di tipo operativo.
Ora, queste associazioni, si fondano prevalentemente sull’operato di persone che soffrono della malattia in questione e che, a lungo andare, non riescono a far fronte, con le energie residue, ad un carico di lavoro che diventa molto gravoso.
Sensibilizzare la comunità di riferimento
I social, che pur svolgono la funzione positiva di mettere in contatto a distanza tra loro persone che patiscono situazioni analoghe, non sono sufficienti a ridurre la sensazione di isolamento che, a lungo andare, favorisce anche l’insorgere di stati depressivi.
Gli amici, disposti a dedicare parte del proprio tempo, diventano in tal senso fondamentali perché consentono di restituire al malato la memoria di ciò che è stato prima dell’insorgere della malattia e di dare un senso maggiore a quella attuale, attenuando la percezione delle sue limitazioni. A sua volta, il Caregiver, può trovare in essi un conforto ed un aiuto concreto in caso di bisogno.
Aumentando le difficoltà di abitare il mondo, il “mondo” sensibilizzato entra nella casa che, da prigione, potrebbe assurgere al rango di punto di incontro.
Gli amici possono costituire un punto di riferimento importantissimo, analogo a quello a suo tempo costituito dalla famiglia allargata. Su questo versante, molto dipende dalla capacità dei protagonisti, passata ed attuale, di creare relazioni sane e forti.
Non tutti rispondono all’appello
Per le più svariate ragioni, non ultima l’ignoranza e l’ineducazione all’ascolto dell’altro, che dipendono dall’egocentrismo, dall’indifferenza, dal timore della malattia su cui è impostato il sistema in cui, oggi, siamo inseriti.
Il discorso sarebbe lungo e non è questa la sede per affrontarlo nella sua interezza.
Qui intendevo comunque porre l’attenzione sulla sensibilizzazione quale presupposto necessario per un risveglio dello spirito di solidarietà, piuttosto sopito.
Finisco citando una frase di una bellissima canzone dell’indimenticabile Giorgio Gaber:
Per approfondire
Lidia Marsili: https://www.facebook.com/lidia.marsili.7
Lidia Marsili: https://autori.poetipoesia.com/minisiti-lidia-marsili/
Lidia Marsili: https://www.ibs.it/libri/autori/lidia-marsili
Cittadinanzattiva Emilia Romagna, Articoli Caregiver:
Carta delle priorità: https://www.cittadinanzattiva-er.it/carta-delle-priorita-del-caregiver/
Caregiver: https://www.cittadinanzattiva-er.it/category/caregiver/