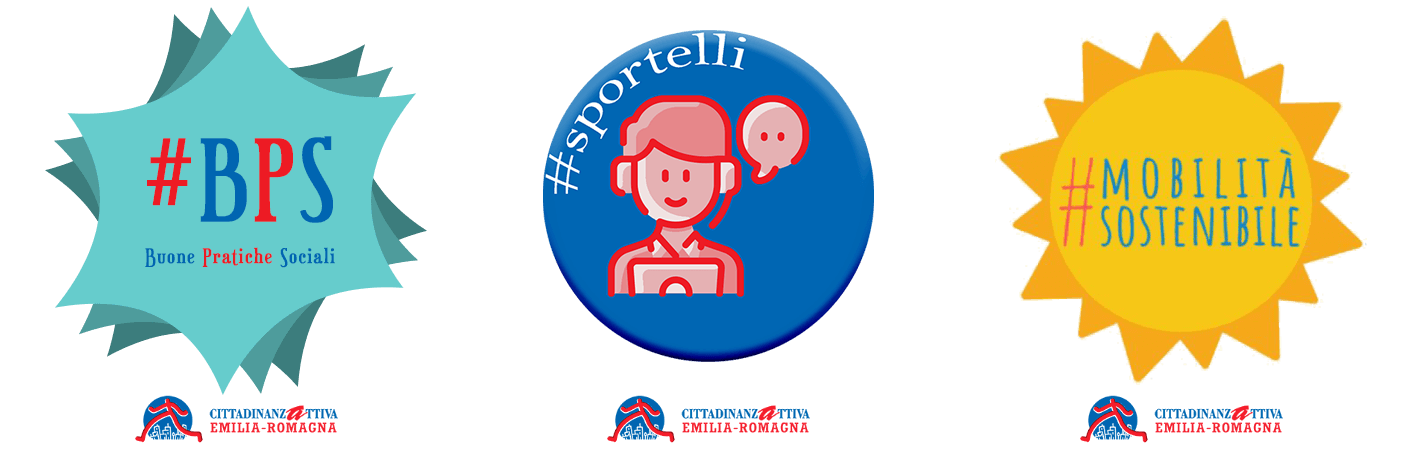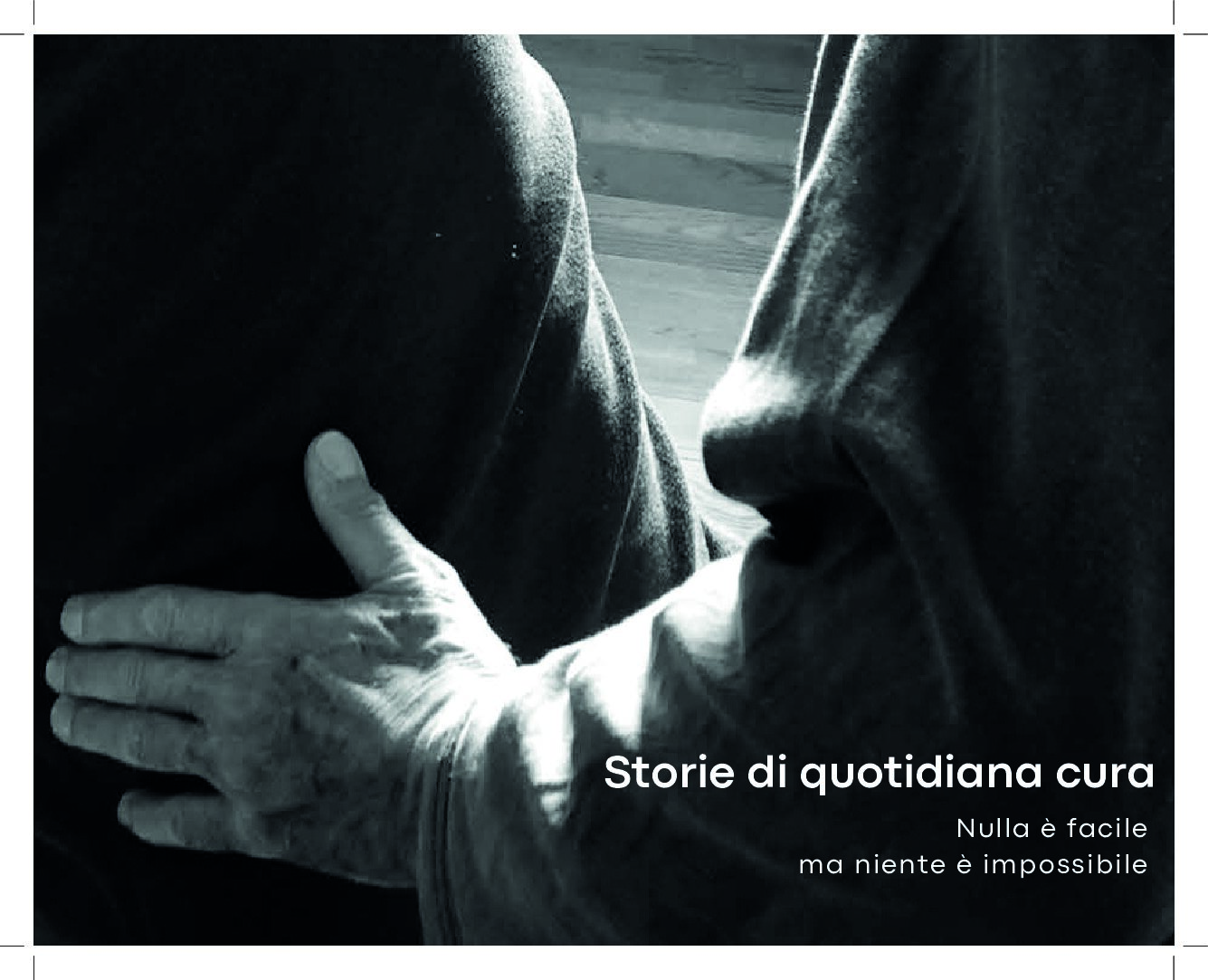(Articolo n°2 Campagna “La cura non è un affare di famiglia”)
A cura di Rossana Di Renzo, Responsabile del Coordinamento delle Associazioni delle Malattie Croniche e Rare-CrAMCR di Cittadinanzattiva Emilia Romagna
Caregiver, le mani invisibili della quotidianità
Il lavoro di cura del caregiver viene spesso considerato “scontato”, “dato per acquisito” e “non riconosciuto a sufficienza, svalutato, se non ignorato”.
I caregiver che vivono situazioni di assistenza per tempi lunghi spesso sono imprigionati dalla fatica, dall’angoscia di non farcela, dalle attese ferite, dalla solitudine, dall’indifferenza e da sogni infranti.
Il loro lavoro di cura è divenuto insostituibile: dove non intervengono i servizi c’è sempre un caregiver che si “interessa a…”, si “prende cura di…” all’interno di una relazione tra chi “presta e chi riceve e viceversa”.
Sarebbe importante integrare questa relazione diadica con il “prendersi cura insieme” per condividere obiettivi sociali e politici di cura con le Istituzioni e con il supporto della Comunità.
Assistere e prendersi cura di un famigliare è qualcosa che accomuna sempre più persone, basti pensare che in Italia sono oltre 8 milioni i caregiver familiari e forniscono l’80% delle cure all’interno delle mura domestiche.
I numeri sono nettamente a favore delle donne, l’86% delle quali è impegnato con diversi gradi di intensità nell’assistenza dei familiari anziani, disabili e/o malati cronici.
Il ruolo della donna
Quello della cura è anche l’ambito che concorre in modo significativo ad accentuare la disuguaglianza femminile.
Infatti, il lavoro di cura informale pone anche una questione di genere vista l’alta percentuale di donne coinvolte nei percorsi di cura e che ritengono “naturale” il loro impegno di assistenza, idea che l’attuale sistema familistico italiano contribuisce a rafforzare.
Una donna su tre si occupa dei propri cari senza ricevere aiuti esterni. Solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia e solo nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno.
Una su quattro è agevolata sotto il profilo lavorativo.
Infine, dobbiamo dire che i dati che disponiamo non sono aggiornati e che quindi non ci permettono di avere una fotografia esatta sia dei numeri, sia delle diversità anagrafiche dei caregiver e quindi dei loro bisogni.
Porre attenzione al caregiver come persona e fornire strumenti e servizi perché possa essere di aiuto al proprio familiare è da considerare solo un aspetto dei suoi bisogni.
La particolare condizione biografica del caregiver non deve far si che si trovi a dover scegliere tra lavoro di cura, lavoro e salute, situazione che caratterizza soprattutto le donne.
Per contrastare le discriminazioni a cui vanno incontro le donne è necessario avviare una vera parità per una cittadinanza garanzia di libertà individuale e di scelte.
Caregiver anch’io
Ognuno di noi, dunque, ha fatto, sta facendo o farà, l’esperienza della vulnerabilità e della conseguente dipendenza, perché tale esperienza non rappresenta un’eventualità rara ed eccezionale, quanto piuttosto, come sostiene la filosofa Eva Kittay essere una “implicazione della nostra stessa natura biologica”.
Per questo nessuna società potrebbe vivere per più di una generazione se i suoi membri non rispondessero in modo adeguato a tale domanda di cura.
Ma cosa vuol dire “prendersi cura“?
La cura è quel sostegno quotidiano di carattere sociale, psicologico, emotivo, fisico che viene rivolto a persone non autosufficienti o fragili.
La cura è un “bene relazionale” la cui qualità dipende dalla qualità della relazione e quindi dall’identità dei soggetti coinvolti e dalla loro storia passata. Questo limita in maniera rilevante la sostituibilità della prestazione e rende, spesso, i caregiver, “prigionieri dell’affetto”.
Il filosofo Umberto Curi, definisce che la: Cura sta a indicare anzitutto la “sollecitudine”, la “premura”, l’”interesse” per qualcuno o (più raramente) per qualcosa, senza che necessariamente questa disposizione affettiva e/o emotiva debba necessariamente concretizzarsi in qualche atto definito.
Avere cura nei confronti di qualcuno vuol dire per prima cosa “stare in pensiero”, “prendere a cuore”, essere “preoccupati” per lui. Se ne trova conferma nel fatto che il termine correlativo alla cura è neglegentia, che indica un atteggiamento di disinteresse o di indifferenza, proprio di chi “non ha riguardi”.
In italiano il termine cura fa riferimento alle azioni terapeutiche esercitate dalla medicina. In italiano quando vogliamo dire che qualcuno a noi caro ha bisogno di attenzioni assidue e affettuose, di assistenza, di impegno diciamo che “ci prendiamo cura” di qualcuno o di qualcosa. Prendersi cura, dunque, allude a un insieme di azioni di sollecita assistenza e di accudimento continuo.
Caring e caregiving
In inglese abbiamo invece i termini caring e caregiving. Il caregiving (Pearilin, Mullan, Semple, & Skoff, 1990) indica tutta una serie diversificate di attività ed esperienze che riguardano il dare aiuto ed assistenza a familiari o amici non più in grado di provvedere autonomamente a se stessi.
Il caregiving coinvolge un’intera gamma di attività, integrando quelle che i servizi non fanno come la somministrazione di farmaci, fornire supporto e igiene di base e tanto altro. Richiede, inoltre, di coordinare le cure formali e informali, di attivare e sostenere reti familiari e amicali, di fornire supporto emotivo e intellettuale.
Il caregiving diventa così un’esperienza estremamente solitaria e faticosa anche per la persona più motivata e determinata. La motivazione al caregiving è prioritariamente volontaria ed è collegata alla qualità dei legami tra i componenti della famiglia, ma può anche essere fortemente influenzata sia da disposizioni caratteriali che da variabili socioculturali (Schultz, O’Brien, Brookwala, & Fleisser, 1995; Teel, Press, 1999).
Il Caring è invece la componente affettiva dell’impegno di una persona (caregiver) verso la salute e il benessere di un’altra (persona malata o persona anziana). L’atto di aiuto è complesso; richiede attenzione, prudenza, costanza e di identificare i bisogni.
Profondo è l’intreccio tra il processo di caregiving e la matrice familiare (Van Gennep, 1981). Ciò è dovuto al fatto che il prendersi cura è, essenzialmente della famiglia, che attraversa con modalità e intensità diversa tutte le fasi del ciclo familiare.
Una narrazione “diversa”
Chi si prenderà cura del caregiver?
Tutti, tuttə insieme per rivendicare la cura come centrale nella vita umana e riflettere sul fatto che essa può mettere in discussione la stessa struttura normativa su cui è fondata la nostra società e rimodellarne di conseguenza le istituzioni.
Ce lo ha spiegato molto bene Carol Gilligan, psicologa dell’Università di Harvard, nel suo importante In a Different Voice (Harvard University Press, 1982) dove viene data voce, appunto, ad un racconto nuovo, narrato in prospettiva femminile, della crescita morale individuale e sociale: “Vedere se stessi inseriti in una rete di rapporti interumani significativi e comprendere come sia tale rete il luogo della nostra fioritura – rappresenta, secondo la Gilligan – il punto d’arrivo di un lungo processo di maturazione morale che ci porta, da una situazione nella quale l’unico interesse è prendersi cura di sé ad un punto in cui comprendiamo che la relazione con l’altro in necessità è un rapporto tra soggetti integrali e non tra uno che si sacrifica e l’altro che beneficia del sacrificio.”
Una bussola di orientamento: le dieci R
Costruiamo insieme comunità più accoglienti e a dare al lavoro di cura dignità e un necessario riconoscimento sociale.
Le dieci R dovrebbero funzionare da bussola di orientamento per noi comunità e per le politiche sociali, sanitarie e di lavoro e far sì che essere caregiver sia una scelta e non un obbligo:
- Riconoscere il ruolo del caregiver e il lavoro di cura non retribuito approvando la proposta del disegno “legge 1461”
- Ridurre il numero totale di ore dedicate alle attività di cura non retribuite; ciò è possibile grazie a un migliore accesso ai servizi e ad una rete di sostegno
- Ridistribuire più equamente il lavoro di cura e trasferirne parte della responsabilità alla Comunità e allo Stato
- Rispettare e promuovere esigenze, ambizioni e talenti dei caregiver nell’arco del loro percorso di vita e di lavoro.
- Rappresentare i caregiver e garantire che abbiano voce in capitolo nella progettazione e nelle iniziative politiche, nella organizzazione di servizi e sostegni che influenzano la loro vita
- Raccomandare di lavorare per eliminare gli stereotipi di genere all’affermazione di un’equa divisione del lavoro di cura fra uomini e donne all’interno della famiglia e nel mondo del lavoro favorendo forme di sostegno
- Reperire risorse economiche, risorse materiali e immateriali a sostegno dei caregiver
- Raccontare e far raccontare la quotidianità del lavoro di cura ai caregiver per conoscere i loro bisogni, sogni e desideri
- Ringraziare i caregiver per il loro impegno che permette alle persone fragili di avere cure e di svolgere una vita sociale, togliendo allo Stato l’onere di dover provvedere direttamente.
- Rifiorire perché ognuno di noi dopo aver attraversato l’inverno ha diritto ad una primavera
Ce la faremo ad approvare la Legge 1461?
Dobbiamo farcela e abbiamo bisogno di voi cittadinə, comunità e istituzioni al nostro fianco.
La cura e l’assistenza è di tutti, difendiamola insieme.
Venite a trovarci nella sede di Cittadinanzattiva Emilia-Romagna per fare proposte, per testimoniare solidarietà, per informazioni, per fare attività con noi e lottare per il riconoscimento dei diritti dei caregiver. Oppure invia una lettera o e-mail (cramc@cittadinanzattiva-er.it) di sostegno/vicinanza. Sarebbe, beh, apprezzata, ne sono sicura.
Approfondimenti e risorse utili per Caregiver familiari
Cittadinanzattiva Emilia Romagna, Articoli Caregiver:
Caregiver: https://www.cittadinanzattiva-er.it/category/caregiver/
Documenti ufficiali Regione Emilia Romagna
(Leggi regionali, Delibere e Determine, Note di indirizzo)
- Legge Regionale 2/2014
- DGR 858/2017 Linee attuative
- DGR 1423/2017 (scheda 5)
- DGR 2318/2019 e nota trasmissione (
306.87 KB) con Indicazioni operative per l’utilizzo delle risorse (
603.35 KB)
- DGR 1005/2020 e nota trasmissione (
788.46 KB); scheda rendicontazione in formato PDF (
44.11 KB) e formato EXCEL (
15.5 KB)
- Determina 15465/2020 – Approvazione schede e strumenti tecnici per il riconoscimento e sostegno del caregiver familiare (
473.71 KB)
- Lettera di trasmissione della determina 15465/2020 (
178.35 KB)
Schede e strumenti tecnici della Regione Emilia Romagna
per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (elaborati dal gruppo di lavoro regionale)
- Allegato 1 – Format progetto personalizzato (
39.26 KB)
- Allegato 2 – Sezione caregiver (
49.53 KB)
- Allegato 3 – Scheda di riconoscimento del caregiver familiare (
114.92 KB)
- Allegato 4 – Indicazioni per utilizzo Format progetto personalizzato e sezione caregiver familiare (
33.4 KB)
- Allegato 5 – Indicazioni per utilizzo Scheda di riconoscimento (
38.14 KB)
- Format informativa privacy (
18.63 KB)
U.Curi, Le parole della cura, Cortina, 2017