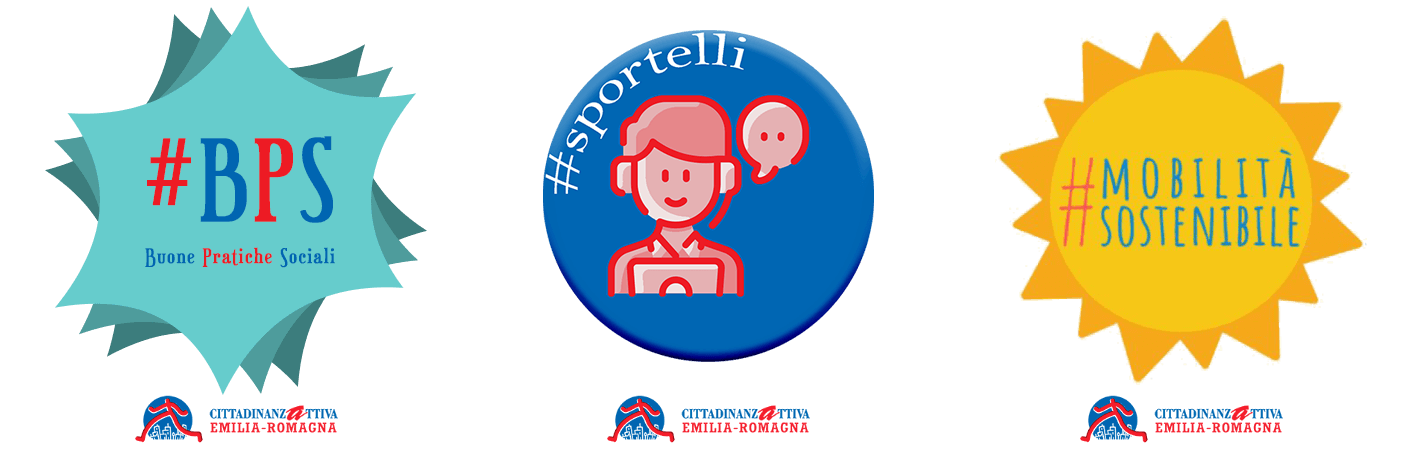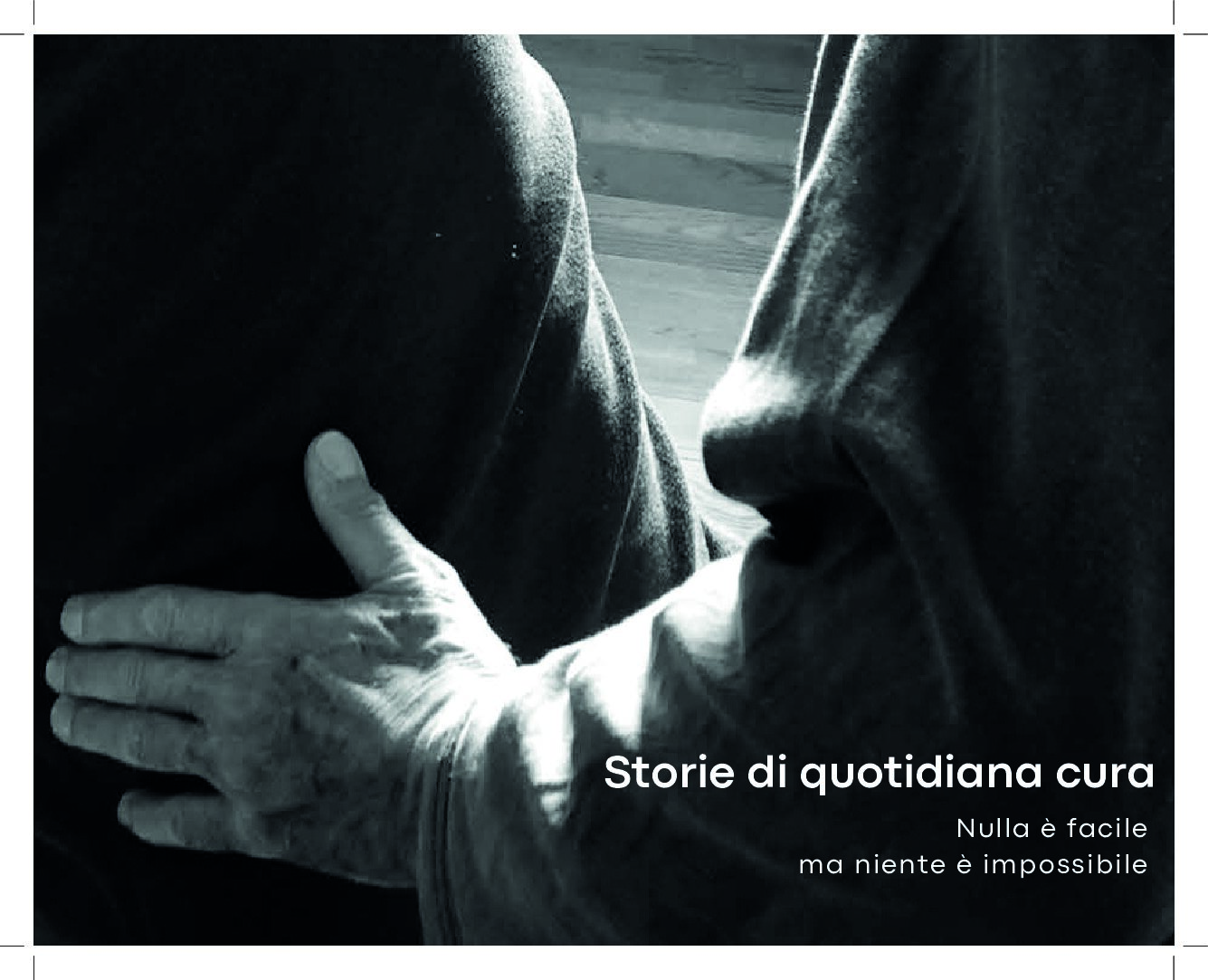di Maria Antonietta Sassani
Le parole danno forma e visibilità al pensiero, evocano immagini, ci consentono di interagire con gli altri, di incidere sulle relazioni, di creare emozioni e di influenzare idee e comportamenti.
E’ questa la loro grande forza, che, come ogni forma di potere, può avere connotazioni positive o negative.
Vi sono parole buone, che trasmettono valori e positività, come pace, amicizia, libertà, rispetto, solidarietà, parole che, insieme, possono diventare il Manifesto della Società Ideale.
E vi sono parole cattive, dure come pietre, che possono ferire, offendere e umiliare, un vero strumento di violenza particolarmente subdolo e con una forza distruttiva meno appariscente ma capace di creare gravi danni.
Lo sanno bene le donne, che, in fatto di violenza, hanno molto da raccontare: spesso, la violenza verbale (espressione dell’aggressività tipicamente maschile) è il mezzo non solo per fare male, ma anche per distruggere l’autostima della donna e con essa la sua forza di volontà, rendendola sempre più fragile e incapace di reagire.
Tante volte, le parole cattive (di solito offensive e volgari) accompagnano la violenza fisica, per dare ancor più risalto, se mai ce ne fosse bisogno, al disprezzo ed alla precisa volontà di colpire la vittima con tutti i mezzi possibili.
Ma le donne hanno capito che vi sono anche altre parole: quelle giuste, quelle che possono aiutarle nel difficile percorso dell’emancipazione, per esempio quelle che sono servite per acquisire e rendere visibile una identità di genere coerente con i cambiamenti che si stavano faticosamente realizzando.
Per lunghissimo tempo molte professioni erano state riservate agli uomini e quando la presenza delle donne cominciò ad affermarsi, emerse la difficoltà di trovare i termini, declinati al femminile, per individuare queste nuove figure.
Era però necessario affermare a tutti, in modo esplicito e chiaro, che se una donna esercitava una data professione, questo le doveva essere riconosciuto pubblicamente; per farlo occorrevano le parole giuste e se non esistevano bisognava inventarle.
Ne era ben consapevole Plautilla Bricci, che, nel 1600, come risulta da un documento conservato nell’Archivio di Stato romano, quando fu posata la prima pietra delle fondamenta della villa che aveva progettato, vi fece inserire una lamina di piombo con incisa una scritta dove rivendicava di essere pittrice e architettrice, come lei stessa si era definita; con altrettanta determinazione, per vincere le resistenze delle maestranze maschili, pretese un atto notarile dove il capo cantiere si obbligava ad obbedire alla “architettrice“.
Non erano atti di vanità, ma manifestazioni di una profonda esigenza di legittimazione e di conferma della propria identità non solo di professionista, ma anche di donna libera, che aveva una vita indipendente ed autonoma, impensabile all’epoca, improntata ad uno spirito autenticamente femminista.
Altrettanto consapevole del proprio valore, Artemisia Gentileschi, vissuta fra il 1500 ed il 1600, volle imporre la propria arte. Fu la prima donna ammessa all’Accademia del Disegno di Firenze ed era chiamata la “pittora”, termine nuovo creato per una nuova professionalità.
Coraggiosa e determinata, denunciò di essere stata vittima di violenza e, nel 1612, per la prima volta un uomo fu processato per stupro. Purtroppo fu lei a patire per tutta la vita le conseguenze di quanto aveva subìto e nei suoi quadri la “pittora” trasfuse tutta la sua disperata voglia di vendetta, creando capolavori che le rendevano giustizia.
Nel tempo, la presenza femminile in tutte le professioni si è affermata sempre di più, ma ancora non abbiamo superato la difficoltà di usare con disinvoltura i nomi di tutte le professioni al femminile.
Eppure non sono mancati i precursori, ad esempio, oltre all’architettrice ed alla pittora, penso a quel monaco che, nel secolo XI, componendo una famosa preghiera, già invocava la Madonna come “avvocata nostra”.
E’ vero che, per alcune professioni e mestieri dove la presenza delle donne è più consolidata, le voci femminili sono ormai diventati di uso comune, ma, ancora oggi, se il medico è una donna la chiamiamo con il generico termine “dottoressa”, comune ad altre professioni, altrettanto vale per il chirurgo, il notaio, l’ingegnere, l’architetto e per altre attività.
Per non parlare del disagio nel rivolgerci ad una donna che è prefetto o questore, sindaco, assessore o cavaliere, oppure che fa l’idraulico, il meccanico o il muratore.
E’ necessario superare queste difficoltà, perché le parole possono aiutarci a definire le persone, inoltre, declinare le professioni al femminile, può contribuire a consolidare ed a fare accettare la presenza delle donne in attività tradizionalmente maschili.
Peraltro, non sussistono neppure ostacoli linguistici, visto che lo stesso Consiglio Direttivo dell’Accademia della Crusca, in un parere reso al Comitato pari opportunità della Corte di Cassazione, ha invitato a fare uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile.
Bisogna soltanto rompere vecchi schemi mentali, radicati in una cultura arretrata rispetto alle innovazioni che le donne hanno voluto e saputo apportare nel mondo del lavoro.
E allora, ben vengano nel nostro vocabolario e nel nostro linguaggio la ministra, la notaia, la sindaca, la medica, la chirurga, la magistrata e tutte le altre voci dello stesso genere; forse dovranno farsi largo fra altre parole (come pregiudizio, discriminazione, diffidenza, abitudine, sospetto, indifferenza), ma sicuramente riusciranno a conquistarsi tutto lo spazio che a loro spetta, con la forza delle parole giuste.
A tutte le donne, buon 8 marzo.
Foto di Lisa Runnels da Pixabay